I racconti del Menico: Natale tiranese
CULTURA E SPETTACOLO - 18 12 2020 - Ivan Bormolini
In vista del Natale, vi proprongo in questa collana dedicata al dottor Domenico Corvi e al suo bel scrivere, il pezzo Natale tiranese. In questo caso l'amico Ezio Maifrè “Mèngu”, che mi ha aiutato all'inizio di questa iniziativa in onore del “Menico” nella raccolta del materiale, ha impreziosito il tutto con delle sue rime dialettali, lo stesso nostro dialetto che il dottor Corvi tanto amava parlare. Buona lettura. ( I.B.) Natale tiranese ( Di Domenico Corvi con parti dialettali di E, Maifrè ) Esisteva un tempo, non poi tanto lontano, in cui il Natale era la festa più attesa dell’anno; si può dire che, passata l’Epifania, tutto il resto dell’anno fosse in funzione dell’attesa del Natale seguente. Era la festa di tutti, grandi e piccini, era l’occasione in cui le famiglie si riunivano di nuovo, attorno all’antico desco; in cui gli emigranti facevano ritorno alle case natali, in cui tutti coloro che la miseria e la ricerca di un guadagno avevano costretto a lasciare il paese riprendevano gioiosamente la strada di casa per poter ancora una volta sedere attorno al vecchio camino, in compagnia dei genitori sempre ogni volta un poco più curvi e stanchi e con lo sguardo sempre meno lucido, quasi sperso nel vuoto dei ricordi. Eppure in quel giorno la gioia tornava a splendere, l’amore si sentiva nell’aria, la carità sgorgava spontanea dal cuore. Tutti i rancori per un giorno si assopivano; le faide fra le famiglie per un giorno trovavano tregua; si arrivava persino ad un accenno di sorriso almeno sulle soglie della chiesa, fra famiglie che da generazioni avevano continuato ad odiarsi e che il giorno dopo avrebbero sicuramente ripreso ad esacrarsi. Era pace per tutti, anche per coloro che per rispettare questa tregua dovevano magari chiudere un occhio sul loro dovere e tradire una consegna, che allora era ritenuta sacra. Mi piace al proposito ricordare un vecchio episodio successo proprio sulle nostre montagne, in questa vecchia Tirano che tanti sacrifici e miserie ha patito nel corso dei secoli. Non posso giurare sulla inconfutabilità dei fatti, ma a me sono stati riferiti come autentici, addirittura col nome dei protagonisti di cui qualcuno tuttora vivente e di cui, per ovvii motivi, debbo tacere le generalità. Io ve la racconto così come m’è stata riferita e a me fa piacere credere che sia vera, perché rispecchia proprio il modo di vivere e di sentire della nostra rude ma sentimentale gente di montagna. Dunque, bisogna ricordare che Tirano, come del resto tutta la nostra bella Valtellina, è sempre stata povera ed i suoi abitanti hanno sempre dovuto strappare alla terra quei pochi frutti, sufficienti a malapena per non morire d’inedia. In ogni caso, la preoccupazione più assillante, era sempre quella della disgrazia improvvisa, della malattia di qualcuno dei componenti della famiglia, perché le medicine e la parcella del medico si sarebbero portati via tutti i pochi risparmi, ammesso che ce ne fossero stati, e in caso contrario , avrebbe significato la disperazione. Va bene che i medici di allora si accontentavano di ben poco e spesso facevano finta di dimenticarsi dell’onorario, quando addirittura non contribuivano essi stessi all’acquisto dei medicinali, ma la povertà non era l’eccezione ma la regola e quindi anche la carità aveva i suoi limiti. Una delle poche entrate extra, per così dire, era il contrabbando che gli abitanti delle frazioni esercitavano. non già in modo massivo ed organizzato, come si è visto negli anni ’60 , ma così , diciamo, in modo artigianale: qualche chilo di caffè o di zucchero da rivendere ai signori della città, in modo da lucrare quell’esiguo margine, quel tanto che sarebbe servito per comprare un paio di scarpe o per pagare gli estimi. Anche i doganieri che spesso come nel fatto che sto per riferire, erano del posto conoscevano la situazione finanziaria di ognuno e, pur cercando di non venir meno al loro dovere per quel senso di onestà che sempre ha contraddistinto le nostre genti, cercavano di chiudere un occhio, quando proprio capivano che un loro troppo drastico intervento avrebbe potuto essere la causa di una tragedia. E veniamo all’episodio che mi è stato riferito e che più di ogni altro sentimento risveglia nell’animo una nota di commossa poesia. Proprio in una notte tra il ventiquattro ed il venticinque dicembre, mentre in tutte le case fervevano i preparativi per celebrare Car Signur che vita gràma! ‘L nòs fiöl l’è a lécc malàa, ‘l ciàma dèbul ‘l pà e la màma, cùma ‘n àngel l’è sénsa pecàa Per tücc nòtri l’è ‘n gran dulur pròpri a Natal che l’è dì de amur vedè ‘l nòs rais dai celèst bei öcc che cun la fébra òlta ‘l varda fìss la òlta negra del nòs tröcc. Car Signur, ‘l nòs prèvat ‘l dìss che chi ‘l crét ‘n dèla Pruvidénsa de ‘n àngel che giüta ‘l resterà mai sènsa. dignitosamente il Natale, in una povera spelonca di Baruffini, un bambino giaceva in un letto divorato dalla febbre; i suoi grandi occhi guardavano sbarrati la volta della cucina nera di fumo, dove in un angolo era il suo giaciglio, senza vedere lo sguardo angosciato della mamma e degli altri fratelli raccolti in silenzio attorno al lume. Il medico era venuto, aveva visitato il piccolo infermo, aveva stilato la sua ricetta e poi se ne era andato, senza accettare nessun compenso per la sua prestazione ma non senza avere raccomandato di iniziare al più presto la cura; sapeva bene che, se anche avesse chiesto qualcosa, si sarebbe sentito umilmente pregare di pazientare per un po’ ; troppa era la miseria in quella casa. Uscito il medico, il padre aveva rovistato nel cassetto del canterano ed aveva cercato sotto le lenzuola ma solo pochi centesimi erano usciti. Del resto in farmacia c’era già un piccolo conto in sospeso e la sua mentalità di galantuomo non gli permetteva di sollecitare ancora un ulteriore prestito. Dalla bassa finestrella della sua casa, aveva allora alzato gli occhi verso la cima del Massuccio ormai incappucciato di neve e dentro di sé aveva capito che l’unica speranza di salvezza avrebbe potuto venire solo da quella parte. Se fosse riuscito durante la notte a contrabbandare qualche chilogrammo di caffè, avrebbe potuto rivenderlo a Tirano il mattino seguente e quindi comprare le medicine. I negozietti al di là del confine erano sempre disposti a fare credito a quella povera gente; anche loro vivevano in una valle non meno desolata della nostra e quindi erano in grado di capire certe situazioni. Così il pover’uomo, gettato un ultimo sguardo alla sua famiglia raccolta attorno al letto del malato, aveva staccato lo zaino dal chiodo e, avvoltosi nel nero tabarro, aveva incominciato a salire faticosamente la china del monte, La notte era serena e fredda come sono di solito le nostre notti d’inverno; il fiato si congelava appena uscito dalle labbra e le mani che cercavano gli appigli offerti dalle sporgenze della montagna erano intirizzite . Ma dentro c’era una grande volontà di andare avanti. C’era la consapevolezza che da quella fatica sarebbe scaturita la salvezza del bambino. Così, superate le Case Alte, girato attorno alla caserma del Sasso del Gallo dove i finanzieri stavano addobbando il loro alberello di Natale, probabilmente pensando con nostalgia alla madri lontane, il pover’uomo finalmente sboccò nei prati di Palù argentati dalla luna e da lì giù nel paesino di Viano, fino a giungere in territorio svizzero. Acquistata la poca merce che riuscì ad avere a credito, riprese la via del ritorno. Adesso si sentiva più leggero; la strada era in discesa e il più ormai era fatto. Ripassato il confine prese a scendere con più scioltezza; in basso si vedevano già le case di Roncaiola e più in là quelle di Baruffini ed in una di quelle il suo piccolo lo aspettava in preda alla febbre. Questo pensiero lo spinse ad allungare io passo; presto ormai sarebbe arrivato e tutto sarebbe stato risolto. Già si era alquanto allontanato dallo sperone incombente del Sasso del Gallo e ormai stava inoltrandosi nel bosco sopra Roncaiola, quando, nel chiarore della luna, gli si parò davanti una spettrale figura: quella del doganiere che, nonostante la fredda notte e la festività, fedele alla consegna, vigilava sul confine. ‘L sciur dutur sénsa paga i l’à visitàa pòo ‘l g’à dìcc a la màma e al pà che ‘n prèsa ‘l ghéra de ès cüràa àa se i ghèi i mancava ‘‘n cà. Sùbit ‘l pà la vardàa ‘l fiöl e po’ de piàch. tabàr ‘n spàla,.‘l sa ‘nviàa per portà fò ‘l sàch, l’ucuréva i centésum per li medisìni! ‘N del turnà a Runcaöla ‘n finansée ‘l crìda: “Trà giù ‘l sàch se de nò ta rüini ! Chèl sàch mulàa l’éra piée de bée e ‘l sgarbasàch dal cör piée d’amur, savüü déla miséria, i ghé l’à ridàcc sénsa fa rumur. L’uomo si sentì raggelare nel profondo del cuore, come se una mano lo attenagliasse alla gola e gli mozzasse il respiro; se avesse ceduto all’intimidazione di “ mollare il sacco “ secondo il tacito accordo in vigore fra i contrabbandieri e le guardie di frontiera, poi sarebbe stato libero di scappare e nessuno si sarebbe preso la briga di inseguirlo; ma abbandonare il carico significava la morte quasi certa per il bambino. In pochi attimi quel poveretto esaminò tutte le possibilità che gli restavano, poi capì che non c’era nulla da fare; se fosse scappato magari gli avrebbero sparato e, se lui fosse morto, anche tutto il resto della famiglia sarebbe morto sicuramente di fame. Così, pur con la morte nel cuore, sciolse gli spallacci e lasciò cadere a terra la bricolla. Dopo di che prese a correre verso la sua casa. Colla coda dell’occhio fece appena in tempo a vedere il doganiere che, raccolto il carico appena abbandonato, prendeva a sua volta la via del paese. Giunse trafelato davanti all’uscio di casa: la sua donna lo aspettava ancora accoccolata vicino al fuoco; il bambino delirava nel suo giaciglio, mentre gli altri avevano ceduto al sonno innocente. Marito e moglie non ebbero bisogno di parlare per capire quel che era successo . Si strinsero l’uno all’altro in silenzio e, senza un commento, si diressero a loro volta sul misero letto imbottito di foglie. Nel loro cuore c’era soltanto una muta disperazione che non permetteva loro di prendere sonno. Stavano lì così da qualche tempo in silenzio, quando un rumore sordo li fece sussultare; qualcuno stava bussando alla porta. L’uomo scese la scala di legno e si avvicinò all’uscio; forse qualcuno più sventurato di lui aveva bisogno di aiuto; non c’è come la miseria per unire la gente. Aprì pian piano l’uscio ma non vide nessuno; solo un po’ più in là, lungo la via, gli parve di intravedere una figura che si allontanava furtiva, quella stessa figura che poco tempo prima gli si era parata davanti a contestagli il suo reato. Sorpreso abbassò gli occhi sul gradino della soglia e lì vide la sua bricolla appoggiata allo stipite, intatta come l’aveva gettata. Il doganiere lo aveva riconosciuto, sapeva della sua tragedia e pur salvando la faccia, non aveva avuto cuore di contribuire ad una tragedia, così gli aveva riportato il sacco fin sulla soglia di casa. Mentre l’uomo portava in casa il suo prezioso carico, un suono di campane pervase l’aria; erano quelle della Madonna di Tirano che annunciavano la nascita del Figlio di Dio. L’uomo cadde in ginocchio e rivolse a Dio il più sentito ringraziamento mentre grosse lacrime gli rigavano le gote. Anche quella notte il miracolo di Natale si era avverato. FONTE: IL TIRANESE N° 4. Ottobre, novembre dicembre 1976. Cooperativa Editrice Tiranese, viale Italia 91 23037 Tirano. Stampa: Tipografia Bonazzi via M azzini 23100 Sondri


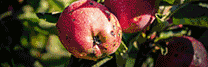







LASCIA UN COMMENTO:
DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.
0 COMMENTI